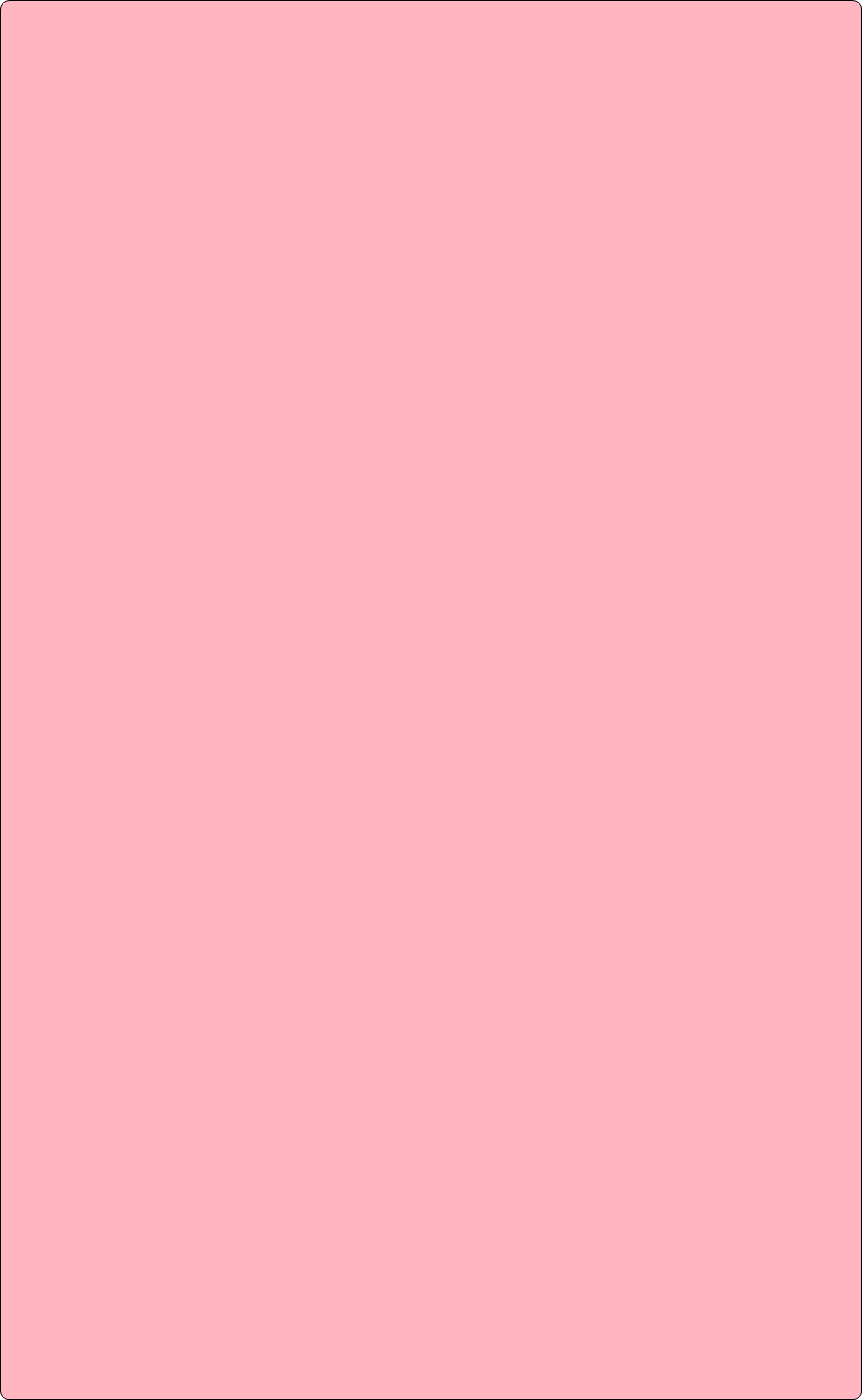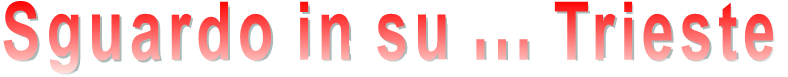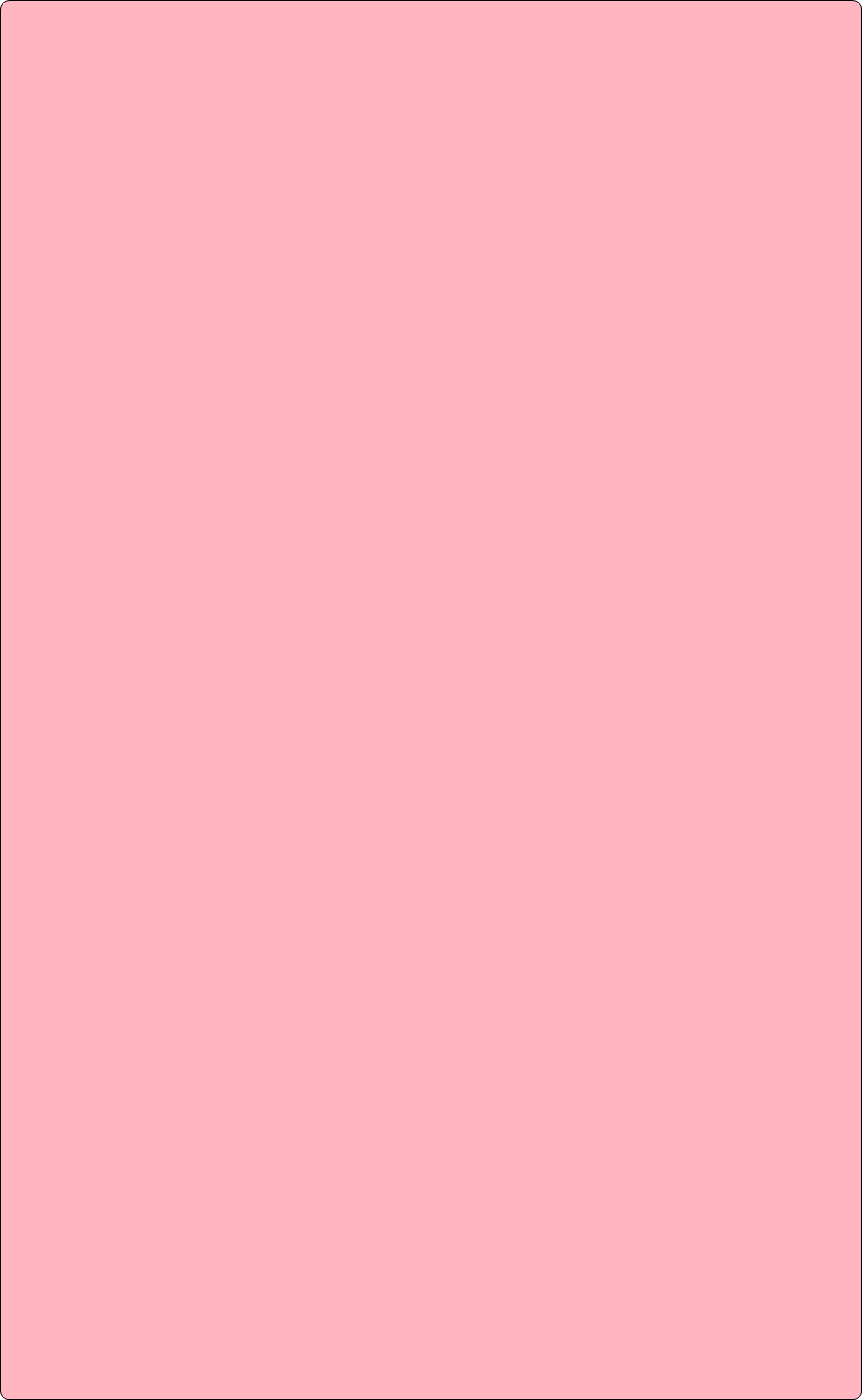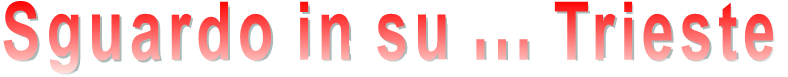Foibe ed esuli a Trieste
Fin dal settembre 1943, il controllo di territori sempre più vasti da parte dei partigiani slavi e soprattutto il rapido disfacimento dell'esercito italiano in Venezia Giulia a seguito dell'Armistizio di Cassibile, permisero le prime eliminazioni, soprattutto in Istria, ma anche nell'entroterra carsico triestino, non solo di elementi fascisti, ma anche di coloro che potenzialmente avrebbero potuto contrastare la politica filocomunista e/o i disegni egemonici sulla Venezia Giulia del maresciallo Tito (italiani soprattutto, ma anche sloveni e croati). Tali uccisioni si intensificarono negli anni successivi e raggiunsero l'apice, a Trieste, con l'entrata dell'esercito Jugoslavo in città e il controllo che esso esercitò sul territorio per circa un mese e mezzo, scarsamente contrastato dal contingente neozelandese di Freyberg. Durante tutto il periodo di occupazione jugoslava furono effettuate dalla polizia titoista requisizioni, confische, arresti di numerosi cittadini, sospettati di nutrire scarse simpatie nei confronti della ideologia comunista o ritenuti inaffidabili per posizione sociale, censo, origini familiari e nazionalità. Fra questi vi furono soprattutto fascisti o collaborazionisti, ma anche combattenti della Guerra di liberazione, semplici lavoratori, vittime di vendette personali e di odii maturati nel corso della guerra. La massima parte degli arrestati non fece più ritorno alle proprie case. I triestini sollecitarono l'intervento degli Alleati che saltuariamente espressero proteste formali senza però ottenere risultati apprezzabili. Il generale Gentry, che condivideva con Freyberg il comando delle forze alleate presenti ebbe anche un incontro col suo omologo jugoslavo e gli fece intendere che gli Alleati « [...] non potevano permettere che si effettuassero arresti sommari o che si allontanassero cittadini dalla città senza processo.», ma tutto fu inutile.
La popolazione triestina non si faceva illusioni sulla sorte dei tanti scomparsi. La scoperta delle prime foibe in Istria, nell'autunno del 1943, le testimonianze dei profughi dalmati sulla tragica sorte toccata a molti loro concittadini a Zara, nel novembre 1944, lasciavano presagire il peggio. Subito dopo il ritiro delle truppe jugoslave da Trieste ebbero inizio gli scavi nel Carso triestino, che furono completati in tempi e periodi diversi. Furono individuate nelle vicinanze della città tre foibe principali: Basovizza, Monrupino e Sesana (attualmente in territorio sloveno), e altre secondarie (Opicina, Campagna e Corgnale), con un numero imprecisato di cadaveri. Va inoltre sottolineato che non tutti gli scomparsi furono gettati nelle foibe summenzionate: una parte non quantificabile di essi venne deportata in altre zone della Venezia Giulia, o in Jugoslavia, e ivi, con ogni probabilità, soppressa e seppellita. Sul numero delle vittime si possono fare solo delle congetture. Nell'aprile 1947 il Governo Militare Alleato aveva raccolto 1.492 nominativi di persone scomparse a Trieste sulla base delle denunce effettuate dai familiari, ma tale numero era da considerarsi provvisorio. Dati definitivi non vennero tuttavia mai forniti né negli anni né nei decenni successivi. Dopo il suo rientro a Trieste, nel marzo 1947, uno dei massimi esponenti del comunismo giuliano, Vittorio Vidali, facendosi interprete della rottura fra Stalin, appoggiato dal PCI, e Tito, si riferì ai «trozkisti titini» definendoli come «una banda di assassini e spie», nel 1956, Chruščёv si reca a Belgrado e riabilita Tito.
A partire dall'estate del 1945 si sviluppò pienamente anche l'esodo di molti giuliani e dalmati dalle zone occupate militarmente dai titoisti e che successivamente sarebbero state annesse allo Stato jugoslavo. L'esodo, che ebbe inizio in forma strisciante fin dal settembre 1943, si protrasse per un quindicennio ed interessò circa 250.000 profughi o forse più (in massima parte di etnia italiana, ma anche sloveni e croati) ed ebbe fra le sue mete privilegiate Trieste. La città accolse infatti gran parte dei circa 65.000 esuli che scelsero di rifarsi una vita nelle province che avrebbero conformato successivamente la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia. Inseritisi perfettamente nella realtà sociale triestina, essi stessi hanno costituito, per la città giuliana, un fattore di sviluppo economico e umano. A tale proposito va ricordato che l'afflusso degli esuli permise a Trieste di sperimentare, nel decennio successivo alla seconda guerra mondiale, una crescita apprezzabile della propria popolazione, con una netta (anche se temporanea) inversione di tendenza rispetto al periodo precedente, caratterizzato da una lunga stagnazione demografica in atto fin dagli anni venti del Novecento.