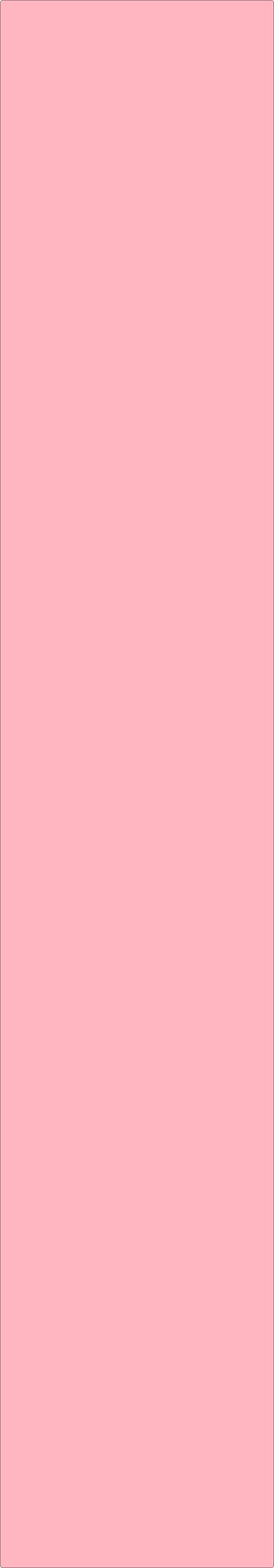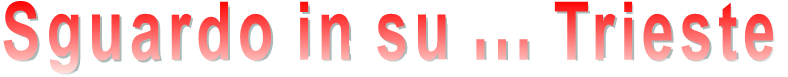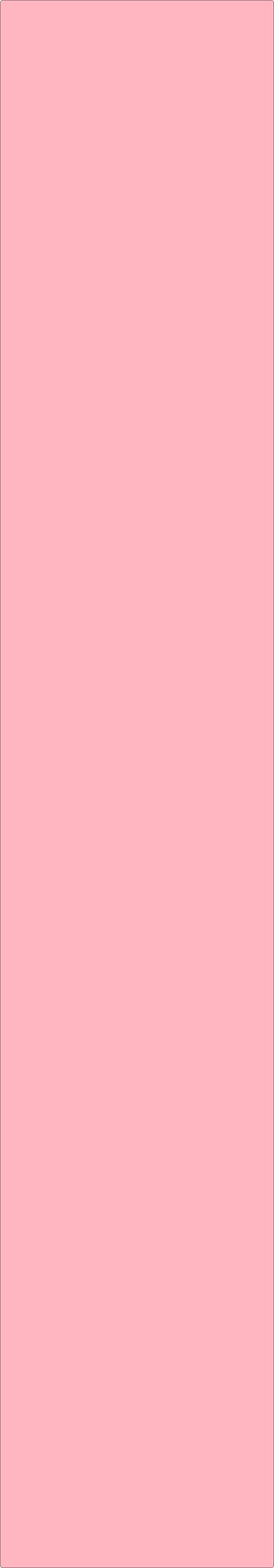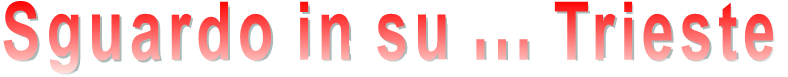Trieste dal 1861 alla prima guerra mondiale
I contrasti nazionali
Le vicende politiche e le lotte nazionali di Trieste nel periodo compreso fra il 1861 ed il 1918 sono state oggetto di una amplissima serie di studi da parte di storici di diverse nazionalità. Le interpretazioni e le visioni storiografiche di questo periodo non sono sempre coincidenti fra loro ed il dibattito permane aperto, quantomeno sotto una serie d'aspetti e problematiche. Appare comunque innegabile che fu un sessantennio segnato da forti tensioni.
Ernesto Sestan mette in evidenza, in tale periodo, la duplice azione di difesa svolta dalla popolazione di lingua italiana, sia in relazione al centralismo burocratico viennese, sia nei confronti della diffusione dello slavismo. I due fenomeni, infatti, soprattutto durante il ministero Taaffe (1879-1893) furono talora concomitanti, dal momento che il governo centrale riteneva più affidabili le popolazioni slave. Al tempo era infatti largamente diffuso il cosiddetto austroslavismo, una corrente politica tramite la quale le popolazioni di lingua slava si prefiggevano il conseguimento dei propri obiettivi nazionali all'interno del regime asburgico e con la sua stessa collaborazione.
Le politiche governative verso Trieste
Le dinamiche della città triestina si trovarono condizionate in questo lasso temporale dalle diverse linee politiche assunte dal potere centrale viennese nei confronti delle istituzioni locali e della questione nazionale.
Fin dal febbraio 1861 il governo imperiale aveva emanato una patente che riduceva l'autonomia delle singole Diete, con la finalità di procedere ad una centralizzazione e germanizzazione dell'amministrazione dell'impero. La decisione provocò reazioni a Trieste, da cui provenne la richiesta di garantire l'autonomia della città, di cui si rimarcava il carattere etnicamente italiano.
Tale politica centralista venne accompagnata, soprattutto a seguito della terza guerra di indipendenza del 1866 e, in generale, del processo di creazione dello stato italiano, da una generale diffidenza o ostilità nei confronti delle popolazioni etnicamente italiane presenti nell'Impero e della loro fedeltà verso lo Stato austriaco e la dinastia asburgica: «Le vicende del 1866 tuttavia rafforzarono in molti ambienti politici austriaci (fra i vertici militari, nell'aristocrazia conservatrice e nella famiglia imperiale) il vecchio sospetto sull'infedeltà e la pericolosità dell'elemento italiano e italofilo per l'Impero. […] Dopo il 1866 la diffidenza dei settori conservatori della classe dirigente asburgica verso gli italiani d'Austria cominciò a tradursi in deliberata ostilità.»
L'imperatore Francesco Giuseppe, nel suo Consiglio della Corona del 12 novembre 1866, pochi mesi dopo il termine della Terza guerra d'indipendenza italiana e relativa annessione del Veneto e della massima parte del Friuli al Regno d'Italia, impose una politica tesa a « [...] germanizzare e slavizzare con la massima energia e senza scrupolo alcuno...» tutte le regioni italiane ancora facenti parte del suo impero: Trentino, Dalmazia, Venezia Giulia. Il verbale recita testualmente: «Sua Maestà ha espresso il preciso ordine che si agisca in modo deciso contro l'influenza degli elementi italiani ancora presenti in alcune regioni della Corona e, occupando opportunamente i posti degli impiegati pubblici, giudiziari, dei maestri come pure con l'influenza della stampa, si operi nel Tirolo del Sud, in Dalmazia e sul Litorale per la germanizzazione e la slavizzazione di detti territori a seconda delle circostanze, con energia e senza riguardo alcuno». Il verbale del Consiglio dei Ministri asburgico del 12 novembre 1866, con le direttive di "germanizzare e slavizzare", è ben conosciuto dagli storici, che lo hanno frequentemente citato nelle loro opere. Esso è riportato da numerosi saggi indipendenti fra loro, compiuti da studiosi di varie nazionalità ed in anni diversi, che ne hanno fornito diverse interpretazioni sui possibili esiti ed applicazioni.
Scrive lo storico Luciano Monzali: «I verbali del Consiglio dei ministri asburgico della fine del 1866 mostrano l'intensità dell'ostilità antitaliana dell'imperatore e la natura delle sue direttive politiche a tale riguardo. Francesco Giuseppe si convertì pienamente all'idea della generale infedeltà dell'elemento italiano e italofono verso la dinastia asburgica: in sede di Consiglio dei Ministri, il 2 novembre 1866, egli diede l'ordine tassativo di opporsi in modo risolutivo all'influsso dell'elemento italiano ancora presente in alcuni Kronländer, e di mirare alla germanizzazione o slavizzazione, a seconda delle circostanze, delle zone in questione con tutte le energie e senza alcun riguardo […]Tutte le autorità centrali ebbero l'ordine di procedere sistematicamente in tal senso. Questi sentimenti antitaliani espressi dall'imperatore, che avrebbero avuto pesanti conseguenze politiche […] negli anni successivi, erano anche particolarmente forti nell'esercito, che aveva combattuto molte guerre in Italia ed era desideroso di rivalsa: considerato il ruolo preponderante dei militari […], ciò era estremamente pericoloso.» Fu così progettato e sviluppato il « [...] piano della classe dirigente conservatrice austriaca di intraprendere una politica di concessioni alle nazionalità slave, ritenute più fedeli all'Impero e ben disposte ad accettare il potere dominante dell'imperatore e dell'aristocrazia asburgica.»
La perdita della massima parte del Friuli e soprattutto del Veneto (con i loro porti ed il personale marittimo qualificato), accrebbe ulteriormente l'importanza economica e strategica di Trieste per l'impero, che aveva nella città giuliana il principale suo sbocco marittimo e commerciale, spingendo lo stato centrale a prestare particolari attenzioni al suo sviluppo ed al potenziamento delle sue infrastrutture. Tale politica, inaugurata dall'Austria subito dopo la terza guerra di indipendenza, si ispirò alle scelte tradizionali, seguite sin dall'inizio del secolo XVIII, di favorire le potenzialità insite nella collocazione geografica di Trieste, posta all'incirca nel punto d'incontro fra le linee di comunicazione convergenti dall'Italia, dalla Mitteleuropa e dai Balcani.
Si ebbe cura dell'apparato stradale e ferroviario che muoveva dall'ampio entroterra in direzione della città e del porto, per poter garantire nel miglior modo possibile la circolazione delle merci e degli uomini nella duplice direzione d'ingresso ed uscita. L'attenzione nei confronti della città da parte del governo centrale s'espresse anche nella scelta dei Luogotenenti imperiali, che furono abitualmente selezionati fra personalità di rilievo.
Al tradizionale settore marittimo, ossia commerciale, si affiancò progressivamente anche quello industriale, che ricevette impulso dalla politica di armamento navale promossa dal governo imperiale a partire dalla fine del secolo XIX in competizione col vicino regno d'Italia e nella prospettiva d'una espansione balcanica. I massicci investimenti destinati al riarmo navale dal governo privilegiarono proprio Trieste, che aveva le strutture materiali ed il personale adeguati per realizzare le opere progettate. Il risultato fu che l'industria triestina, specie in settori come quello siderurgico e nella cantieristica in senso stretto, conobbe una grande espansione. A questa parziale metamorfosi dell'assetto economico cittadino contribuì anche la decisione presa dalle autorità imperiale nel 1891 di restringere le tradizionali franchigie doganali (risalenti in pratica fin dal lontano 1719, data della concessione del cosiddetto porto franco) alla sola area portuale e non più all'intera città.
Trieste era inoltre un centro finanziario ed amministrativo rilevante, sia per i capitali che s'accumulavano con il commercio o che affluivano da investitori stranieri, sia perché era divenuta sede già nel 1850 dell'istituzione del cosiddetto Governo centrale marittimo. Si trattava di un organo chiamato a disciplinare e controllare nell'unità amministrativa del Litorale austriaco le attività legate al commercio nei suoi vari aspetti.
Un rilevante tramite fra Vienna e Trieste era costituito dal Lloyd. Difatti due settori cruciali dell'economia triestina, quelli della navigazione e delle assicurazioni, avevano un punto di riferimento importante nel Lloyd austriaco, poiché esso rappresentava la società capace di collegare fra loro capitale pubblico e privato, nonché imprenditoria viennese e triestina.
Trieste conobbe pertanto, nei decenni finali dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento, un grande sviluppo economico, favorito da una serie di condizioni: il contesto storico costituito dallo slancio dell'economia europea e dall'intensità dei traffici marittimi mondiali che, dopo l'apertura del canale di Suez, vissero la loro epoca aurea; la presenza di un tessuto urbano attivo e mediamente qualificato; gli investimenti pubblici e gli stretti legami commerciali con un esteso entroterra mitteleuropeo propiziati dalla rete di infrastrutture.
La politica di collaborazione con i serbi locali, inaugurata dallo zaratino Ghiglianovich e dal raguseo Giovanni Avoscani, permise poi agli italiani la conquista dell'amministrazione comunale di Ragusa nel 1899. Nel 1909 la lingua italiana venne vietata però in tutti gli edifici pubblici e gli italiani furono estromessi dalle amministrazioni comunali. Queste ingerenze, insieme ad altre azioni di favoreggiamento al gruppo etnico slavo ritenuto dall'impero più fedele alla corona, esasperarono la situazione andando ad alimentare le correnti più estremiste e rivoluzionarie.
Tensioni e contrasti politici, sia interni a Trieste, sia fra il comune triestino ed il governo centrale, si ebbero negli anni in cui il principe Konrad di Hohenlohe fu governatore imperiale della regione (dal 1904 al 1915), poiché egli era un sostenitore del cosiddetto trialismo e seguiva una politica filoslava. Il trialismo era un progetto politico sostenuto dall'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este (erede al trono designato di Francesco Giuseppe e di fatto reggente, all'epoca, data la tarda età dell'imperatore), che si proponeva di creare un terzo regno nell'impero, accanto a quelli d'Austria e d'Ungheria: la Slavia danubiana, che avrebbe dovuto includere anche Trieste e il Litorale austriaco. Era infatti volontà del governo austriaco « [...] indebolire i poteri e la forza politica ed economica del comune di Trieste controllato dai nazionali-liberali italiani, ritenendolo giustamente il cuore del liberalismo nazionale in Austria e delle tendenze irredentiste». Questo prevedeva anche la recisione degli « [...] stretti rapporti politici, culturali e sociali fra i liberali triestini e l'Italia.».
La questione scolastica
Una questione che suscitò forte interesse e talora grandi passioni fu quella scolastica, poiché l'insegnamento era visto come una forma essenziale di trasmissione e conservazione della cultura nazionale. Il sistema educativo imperiale era piuttosto complesso e differenziato, poiché destinato ad una molteplicità di etnie racchiuse in un medesimo stato. Semplificando per brevità, si può presentare la seguente distinzione per la città di Trieste nel periodo in esame: esistevano le scuole primarie in cui l'insegnamento era tenuto nella lingua familiare (la lingua paterna ovvero materna) o meglio nella cosiddetta lingua d'uso adoperata abitualmente dagli studenti, ma che prevedevano comunque l'obbligo del tedesco come seconda lingua; esistevano poi scuole secondarie, che a Trieste avevano come lingua d'insegnamento o quella usata dalla maggioranza della popolazione e dal ceto colto e degli affari (l'italiano) oppure la lingua ufficiale ed amministrativa dell'impero (il tedesco). La complessità era accresciuta dall'esistenza di scuole statali e comunali, di istituti con sezioni parallele con diversa lingua di insegnamento ed ancora dal notevole numero di ore dedicate in alcuni istituti a determinate lingue (italiano, tedesco, sloveno), ma come materia d'apprendimento anziché quale lingua d'istruzione.
Le autorità imperiali cercarono di diffondere il più possibile l'insegnamento in lingua tedesca ed, in parte, anche slovena. Gli stessi libri di testo furono sottoposti a rigide forme di censura, con esiti anche paradossali come, in alcuni casi, lo studio della letteratura italiana su testi tradotti dal tedesco o la proibizione di studiare la stessa storia di Trieste, perché ritenuta "troppo italiana". Per tali ragioni la Lega Nazionale italiana ebbe, fra i suoi obiettivi principali, la promozione di istituti scolastici ed educativi destinati alla difesa culturale del gruppo etnico italiano.
A Trieste, tra il 10 e il 12 luglio 1868, vi furono manifestazioni a favore della libertà d'insegnamento successive a una petizione firmata da 5.858 cittadini e presentata all'Inclito Consiglio della città, in cui si richiedeva il diritto di usare la lingua italiana nelle scuole statali. Tali manifestazioni degenerarono in scontri e violenze nelle principali strade cittadine, con gli sloveni locali arruolati fra i soldati asburgici, che provocarono la morte dello studente Rodolfo Parisi, ucciso con 26 colpi di baionetta e di due operai Francesco Sussa e Niccolò Zecchia. A testimonianza del carattere acceso assunto dalla questione scolastica, va ricordato che si ebbero ancora altri violenti scontri. Nel 1914 vi fu un modesto tafferuglio presso la Scuola Superiore di Commercio Pasquale Revoltella fra studenti italiani e slavi, legato ad una questione linguistica. La società universitaria slovena Balcan decise d'intervenire, in teoria in segno di protesta, cosicché pochi giorni più tardi (13 marzo del 1914) vi furono altri scontri, di una gravità ben superiore ai precedenti, che provocarono la morte di uno studente italiano colpito da una pallottola nel corso di una sparatoria.
Altro punto della questione scolastica che provocò duri contrasti fu la richiesta di consentire la istituzione di una università in lingua italiana a Trieste. La domanda era stata avanzata sin dal 1848 ed era divenuta più pressante dopo il 1866, giacché gli studenti triestini (ed in generale gli Italiani che erano sudditi di Vienna) vedevano ora frapporsi la frontiera fra loro e l'università italiana di Padova, in cui in precedenza era soliti recarsi a studiare. Lo stato centrale austriaco riconosceva in linea di principio la legittimità della richiesta di istituire un'università italiana a Trieste, ma negava la concessione sia per il timore di scontentare il gruppo sloveno o di vederlo avanzare una richiesta analoga, sia perché prevedeva che un centro culturale e di studi di tale tipo avrebbe finito col rafforzare l'irredentismo italiano.
La questione lavorativa
Il grande centro urbano, industriale e commerciale di Trieste attirava un intenso movimento migratorio dalle regioni vicine, sia dell'impero, sia dello stato italiano. Giungevano così nella città triestina immigrati di molte nazionalità, fra cui principalmente Italiani e Slavi del sud. Sorsero all'epoca forti timori nella comunità italiana riguardo all'eventualità che l'impero favorisse l'immigrazione slava a Trieste ed al contempo sfavorisse quella italiana.
Tuttavia il movimento migratorio slavo in direzione di Trieste era determinato anzitutto da ragioni socioeconomiche, poiché dovuto “fondamentalmente a motivi di carattere economico e alla forza di attrazione esercitata sul circondario dalla città in espansione”. Gli Sloveni trovavano con più facilità lavoro in impieghi pubblici in una zona mistilingue per ragioni d'ordine linguistico ed inoltre erano sovente bene accolti dai datori di lavoro italiani in settori che andavano da quello industriale al lavoro domestico. Il Sestan puntualizza che la diffidenza delle autorità imperiali verso gli immigrati Italiani era dovuta al fatto che questi erano cittadini d'uno stato straniero.
Si deve però aggiungere, come riconosce Angelo Ara, che «senz'altro esisteva un interesse imperiale a rafforzare la componente slavo-meridionale, ritenuta più leale e "centripeta" di quella italiana»: questo atteggiamento fu, ad esempio, riconosciuto dallo stesso governatore Hohenlohe in un suo documento ufficiale. Anche il Sestan fa notare dal canto suo come le autorità austriache favorissero l'immigrazione slava dalle regioni contadine della Slovenia e della Croazia ed al contempo ostacolassero il movimento migratorio d'Italiani provenienti dal regno. Per portare un esempio specifico, la Luogotenenza imperiale cercò d'inserire nell'elenco degli scaricatori del porto di Trieste degli sloveni residenti in altri Comuni del Carso e della Carniola. Le autorità imperiali si mostravano diffidenti nei confronti degli immigrati regnicoli e ricorrevano con facilità a misure d'espulsione nei loro confronti: «la cittadinanza del regno d'Italia […] era motivo sufficiente perché le autorità austriache facessero il viso dell'arme e quando credessero opportuno, intervenissero con provvedimenti di sfratto forzoso, con i più futili pretesti; 35 mila circa sarebbero state queste espulsioni di italiani regnicoli nel decennio dal 1903 al 1913, fino cioè ai famosi decreti del luogotenente di Trieste principe Corrado di Hohenlohe». Questo contribuì ad esasperare gli animi fra i diversi gruppi etnici. Nel 1913, dopo un altro decreto del principe Hohenlohe che prevedeva espulsioni d'italiani, i nazionalisti slavi suoi sostenitori tennero un pubblico comizio contro l'Italia, per poi svolgere una manifestazione al grido di “Viva Hohenlohe! Abbasso l'Italia!”, tentando poi di assaltare lo stesso Consolato italiano.
Il più rapido accrescersi della componente slava a Trieste ad inizio del secolo XX era quindi dovuto sia a ragioni socioeconomiche, sia alla politica dell'impero e di Hohenlohe (simpatizzante per le posizioni trialistiche di cui sopra si è detto). La conseguenza comunque era che la città triestina vedeva così erodere la propria italianità dal movimento d'immigrazione slavo, senza poter da sola crescere demograficamente in modo corrispettivo. I timori della comunità italiana di Trieste erano ad inizio Novecento accresciuti dalla conoscenza di quanto era avvenuto in Dalmazia, con “il calo dell'italianità dalmata” che è “percepito drammaticamente dagli altri adriatici e soprattutto dai triestini, che lo attribuiscono all'aggressivo espansionismo slavo-meridionale e all'intervento governativo”, cosicché vedono nella situazione della Dalmazia "quasi l'anticipazione di quello che in futuro avrebbe potuto verificarsi a Trieste”.
L'irredentismo e la Grande guerra
Trieste fu, con Trento, oggetto e al tempo stesso centro di irredentismo, movimento che, negli ultimi decenni del XIX secolo e agli inizi del XX aspirava ad un'annessione della città all'Italia. Ad alimentare l'irredentismo triestino erano soprattutto le classi borghesi in ascesa (ivi compresa la facoltosa colonia ebraica), le cui potenzialità ed aspirazioni politiche non trovavano pieno soddisfacimento all'interno dell'Impero austro-ungarico. Dal canto suo, come si è già indicato, il gruppo etnico sloveno era nella città triestina agli inizi del Novecento in piena ascesa demografica, sociale ed economica, e, secondo il discusso censimento del 1910, costituiva circa la quarta parte dell'intera popolazione. L'irredentismo assunse pertanto, nella città giuliana, dei caratteri spesso marcatamente anti-slavi che vennero incarnati dalla figura di Ruggero Timeus.
Primo esponente di tale movimento è considerato il triestino Wilhelm Oberdank, poi italianizzato in Guglielmo Oberdan, che, per aver ordito un complotto per uccidere l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe e trovato in possesso di due bombe orsini, fu processato ed impiccato nella sua città natale il 20 dicembre 1882. Vicina al movimento irredentista italiano e percepita come tale dalle autorità austriache, fu la già citata Lega Nazionale, massima organizzazione triestina di carattere privato del tempo, che arrivò a contare 11.569 soci nel 1912. Il 23 maggio 1915, alla notizia della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria-Ungheria, vennero incendiati da dimostranti filoaustriaci, oltre alla sede della Lega Nazionale, il Palazzo Tonello dove si trovava la redazione del quotidiano irredentista "Il Piccolo" e l'edificio della Ginnastica Triestina, associazione sportiva irredentista.
Allo scoppio della prima guerra mondiale, 128 triestini si rifiutarono di combattere sotto le bandiere austro-ungariche e, subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia contro gli Imperi centrali, si arruolarono nel regio esercito. Fra i volontari che persero la vita nel corso del conflitto, si ricordano gli scrittori e intellettuali Scipio Slataper, Ruggero Timeus e Carlo Stuparich, fratello del più noto Giani. Particolarmente attivi sul fronte delle idee e della propaganda furono i fuoriusciti triestini in Italia e Francia, dove ebbero un ruolo di primaria importanza nella fondazione, a Roma, di un Comitato centrale di propaganda dell'Alto Adriatico (1916) e, a Parigi, dell'associazione Italia irredenta. Tutti i membri degli organi direttivi del Comitato erano triestini, ad eccezione del dalmata Alessandro Dudan. Tra 1915 e 1917 l'aviazione italiana bombardò la città in numerose occasioni, causando numerose vittime tra la popolazione civile.
Secondo una calcolo di stima, invece, i cittadini del Litorale Austriaco di lingua italiana arruolati con la divisa dell'impero austro-ungarico furono, dal 1914 al 1918, circa 50 000.
Il 4 novembre 1918 le truppe italiane entrarono a Trieste, dopo aver atteso che le truppe austriache lasciassero la città.
Annessione all'Italia
In quello stesso mese di novembre (1918), al termine della prima guerra mondiale, Trieste fu occupata dal Regio Esercito, sotto il comando del generale Carlo Petitti di Roreto. L'annessione formale della città e della Venezia Giulia al Regno d'Italia avvenne però solo il 12 novembre 1920 con il trattato di Rapallo. Con l'annessione, l'importanza della metropoli giuliana venne alquanto ridimensionata: Trieste si trovò ad essere città di confine con un hinterland molto più limitato che in passato. Il suo porto aveva inoltre perduto il potenziale bacino di utenza che ne aveva determinato lo sviluppo e che era costituito dall'intero Impero austro-ungarico, entità statuale dissoltasi definitivamente. Per ovviare almeno parzialmente a tale situazione lo stato italiano mise in atto nei confronti della città e della sua provincia una politica di economia assistita che, avviata dall'ultimo governo di Giovanni Giolitti (1920-1921), si protrasse durante tutto il periodo fascista (1922-1943). Lo sforzo maggiore venne fatto nel settore industriale, che, nelle intenzioni dei legislatori, avrebbe dovuto sostituire il porto e le attività commerciali ad esso legate, come volano dell'economia triestina.