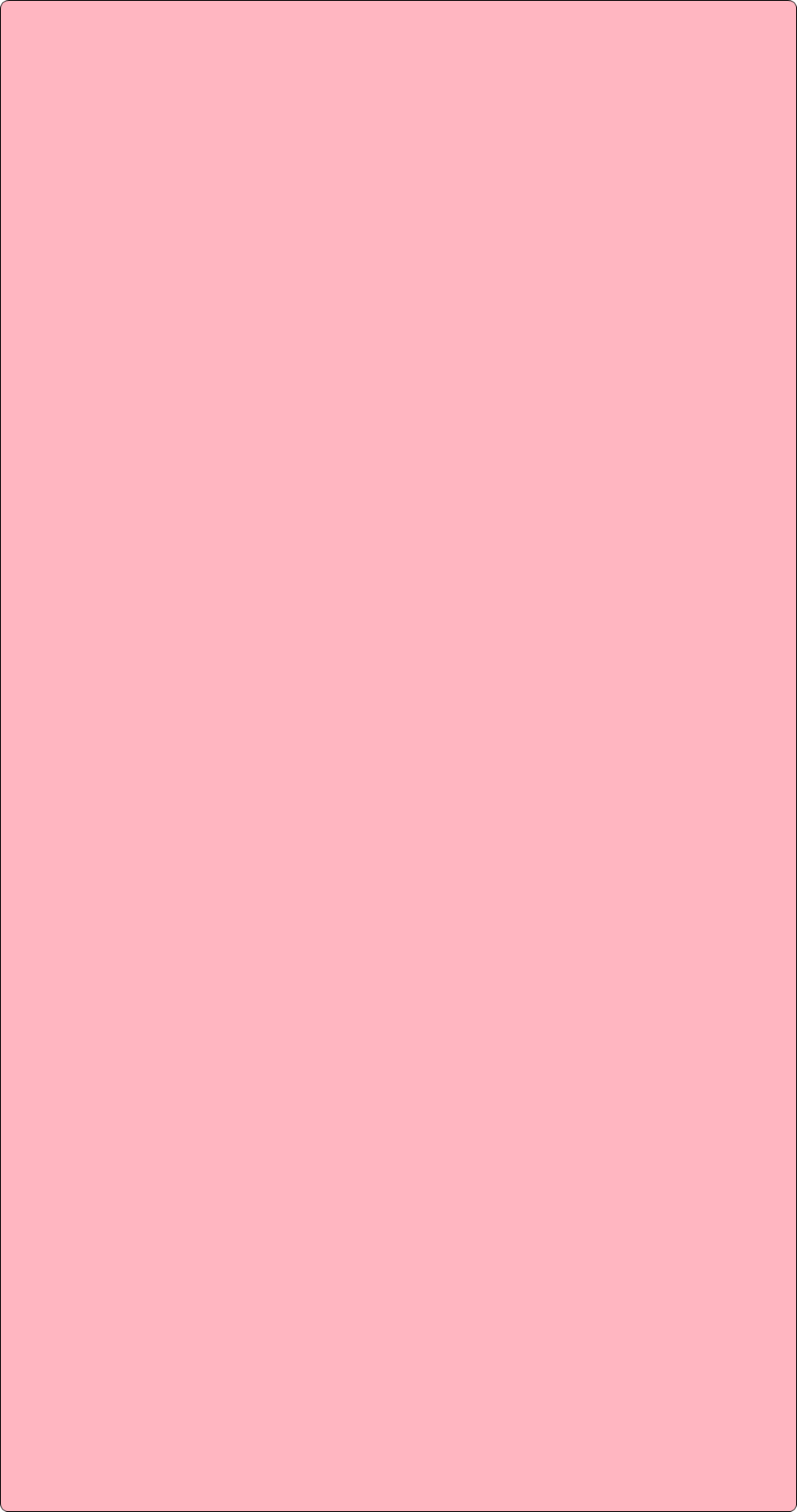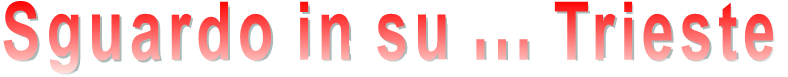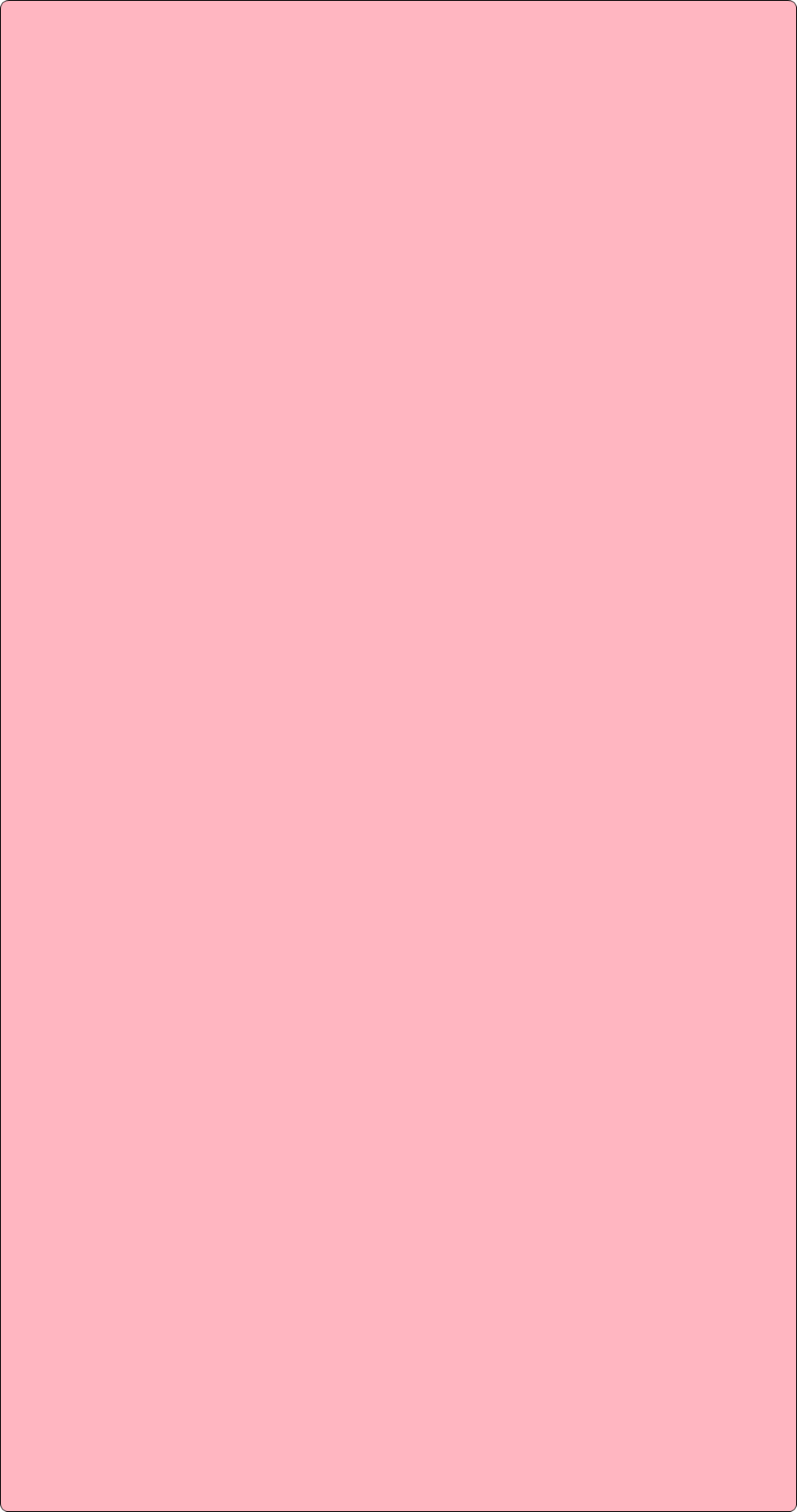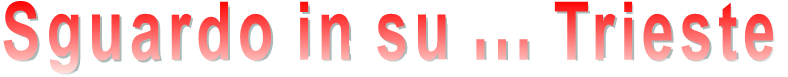Teatro Verdi (1798 - 1801)
piazza Verdi 1
Arch. Giannantonio Selva
I progetti iniziali elaborati da Giannantonio Selva (1751-1819), già celebre ed apprezzato architetto autore del Teatro La Fenice di Venezia, vennero ripresi e parzialmente modificati dall'architetto Matteo Pertsch (1769-1836) il quale, agli inizi della sua attività, stava ultimando la costruzione di Palazzo Carciotti. Tra le varie aree proposte per l'edificazione venne scelta quella prospiciente al mare, ai margini del Borgo Teresiano. L'edificio, di notevole importanza per la sua pubblica funzione, si trovò così ad essere inserito in un contesto urbanistico dove convergevano molteplici attività ed interessi sociali.
La vicenda progettuale si presenta piuttosto complessa. L'edificazione fu intrapresa per iniziativa di Giovanni Matteo Tommasini, negoziante di Borsa, che era riuscito ad ottenere l'autorizzazione dal Governo centrale di Vienna. Egli affidò l'elaborazione dei disegni a Giannantonio Selva, ma i due diversi progetti che l'architetto presentò nel 1798 non furono integralmente approvati.
La distribuzione dell'interno, che presentava affiancata alla sala teatrale una sala da ballo, o Ridotto, di notevoli dimensioni e nettamente separata dagli altri ambienti (tra cui anche magazzini ed appartamenti), fu ritenuta essenzialmente accettabile, mentre non soddisfecero le elaborazioni per la facciata principale.
Nella facciata postica Selva impiegò largamente il bugnato, e progettò un grande portone ad arco sormontato da un timpano e affiancato da due nicchie con statue. Un gruppo statuario con dedica all'Imperatore coronava l'edificio. Sebbene non interessato da considerazioni negative, in fase di edificazione il disegno fu parzialmente modificato. Il 9 marzo 1799 venne conferito l'incarico di elaborare un nuovo progetto per la facciata principale all'architetto Matteo Pertsch e gli si affidò la direzione dei lavori, allontanando Selva.
Dopo molte difficoltà ed il licenziamento anche di Pertsch da parte di Tommasini, l'edificazione del teatro fu portata a compimento. L'inaugurazione avvenne il 21 aprile 1801.
Sorto come "Teatro Nuovo", l'edificio fu chiamato "Teatro Grande" nel 1820, divenne proprietà comunale nel 1861 e fu infine intitolato "Giuseppe Verdi" nel 1901, primo tra i teatri italiani ad essere intitolato al grande compositore in una terra appartenente all'impero austriaco.
La facciata principale, opera di Matteo Pertsch, si presenta come l'elemento più notevole e di maggior monumentalità nell'ambito della Piazza del Teatro su cui si affaccia.
Risultato sia di un'intelligente elaborazione del progetto di Selva che di una rispettosa conformità alle richieste della committenza, la sua linea architettonica riconduce anche a quella del Teatro alla Scala di Milano, rispetto a cui la diversa distribuzione degli elementi compositivi ne determina il carattere più disinvolto. L'ordine ionico gigante delle colonne e delle paraste scandisce una slanciata geometria ove l'elemento decorativo, elegantemente sobrio, si distribuisce con una continua e viva ritmicità.
Armonia compositiva ed assenza di compiacimenti stilitici caratterizzano l'insieme mentre il portico, robusto ed arioso con arcate a tutto sesto, conferisce equilibrio ed importanza alla facciata articolata nella fascia superiore con un lieve sovrapporsi di piani.
La facciata verso il mare, realizzata nel 1884 dall'ingegnere Eugenio Geiringer (1843-1904), riprende lo schema e gli elementi compositivi di quella principale. Fu edificata distanziandola sei metri da quella originaria, della quale sono visibili alcune parti all'interno del teatro, fra le strutture del palcoscenico.
Le sculture che adornano la facciata del Teatro pongono tuttora problemi di attribuzione, tuttavia nel volume "Tre giorni a Trieste", 1858, il gruppo e le statue sono attribuite agli scultori veneti Antonio Bosa e Bartolomeo Ferrari. Il soggetto scelto per il gruppo scultoreo posto a coronamento dell'edificio si riferisce direttamente all'arte musicale: Apollo al centro tra le figure allegoriche dell'Arte Lirica e dell'Arte Tragica, assise ai suoi piedi, attorniate da maschere teatrali e strumenti musicali. Il tema musicale viene riproposto sotto il cornicione del tetto, dove pannelli decorativi a bassorilievo rappresentano diversi strumenti musicali inseriti in serti vegetali. Nelle nicchie situate ai lati estremi del basamento dell'edificio si inseriscono due statue rappresentanti Marte a destra e Plutone con il cane Cerbero a sinistra.
Al piano nobile dell'edificio, con accesso da via San Carlo, si trova l'antica Sala da Ballo (o Ridotto), già sede del Circolo della Cultura e delle Arti. Costruita seguendo il progetto di Giannantonio Selva, si configura in una sala rettangolare con colonne ioniche a sostegno di una galleria. Rinnovata più volte nella decorazione, venne notevolmente rimpicciolita nel 1882-1884 da Eugenio Geiringer.
Gli ambienti interni del teatro furono più volte restaurati. Nel 1820 il pittore milanese Alessandro Sanquirico decorò la sala della platea, nel 1835 il medesimo intervento fu affidato a Tranquillo Orsi e Giuseppe Gatteri e nel 1846 si sostituì alle ornamentazioni pittoriche il legno intagliato e dorato. Le decorazioni interne tuttora visibili vennero invece eseguite da decoratori austriaci nel 1882-1884.